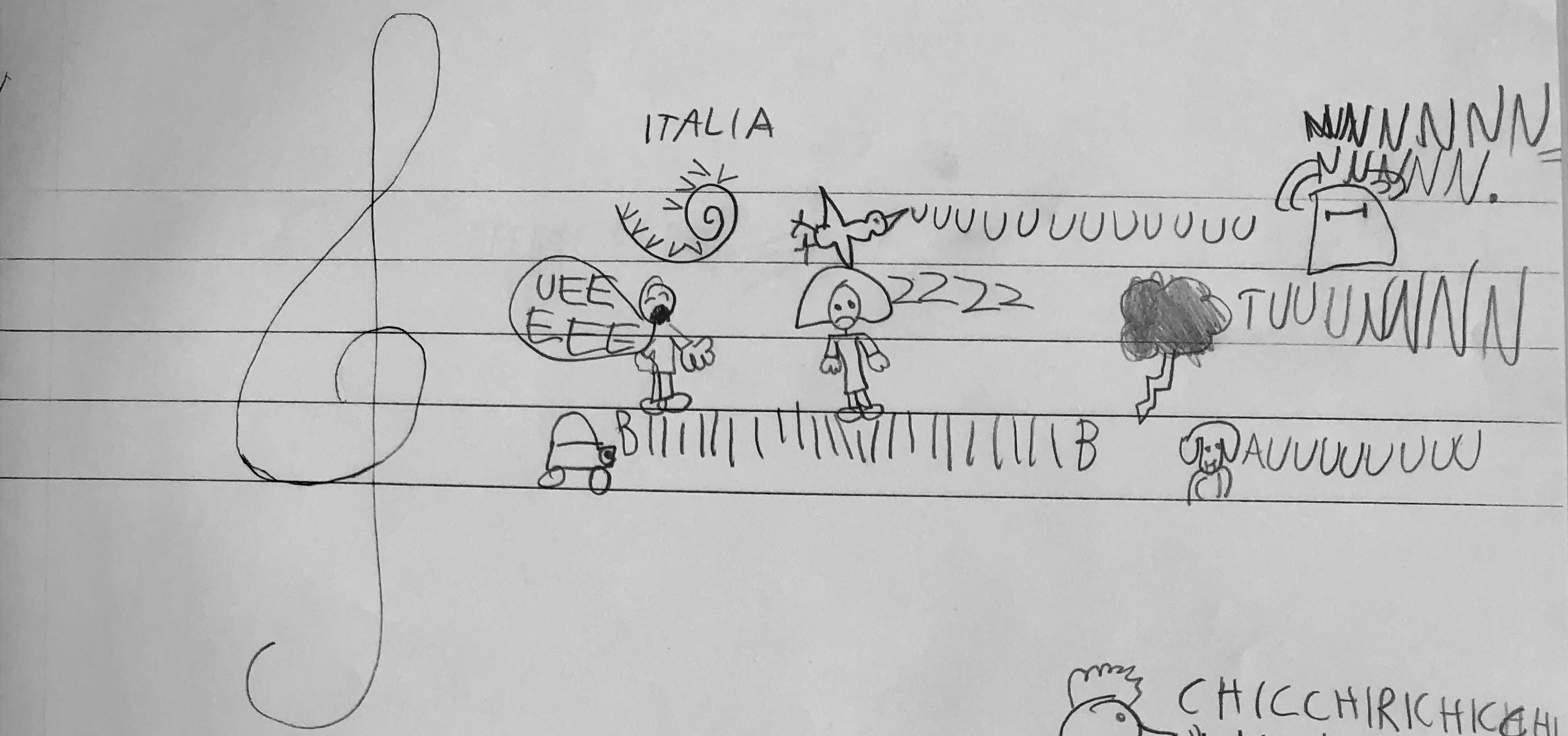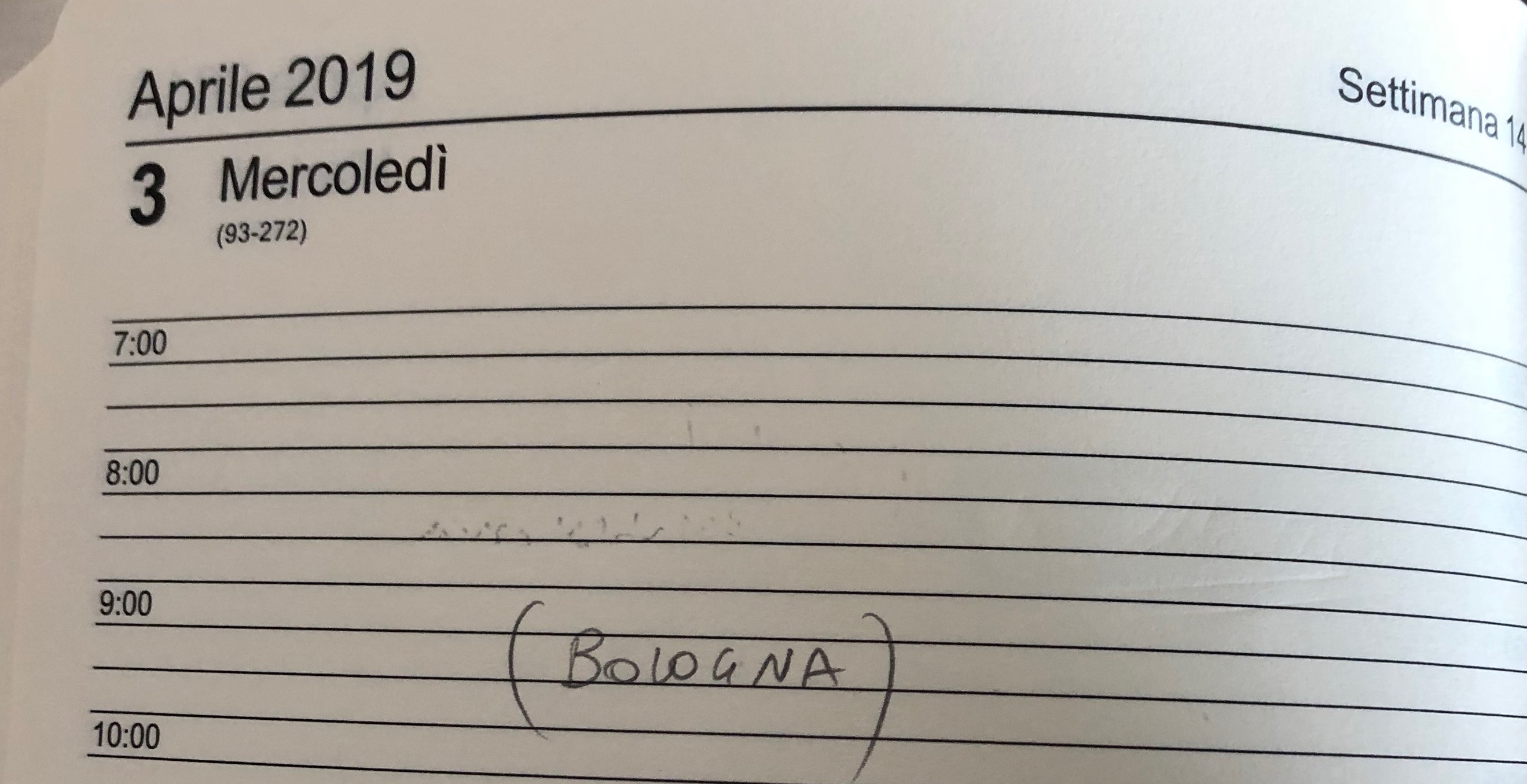Se un bambino di sette anni fa la fila per leggere a voce alta un suo testo (diciamo che pretende di leggerlo), un bambino di dieci anni non ha difficoltà a leggerlo, ma può anche facilmente rinunciarvi e un ragazzo di tredici anni ci rinuncia già prima che qualcuno glielo chieda. Dal punto di vista degli insegnanti, succede un po’ la stessa cosa, che più si cresce e si va avanti e più ci si distacca dall’idea di doversi mettere in gioco a viva voce.
Mi è capitato di lavorare con insegnanti, già impegnati da diversi anni a scuola, che dimostravano le proprie difficoltà e la propria diffidenza verso un lavoro fatto sull’esecuzione della lettura di un testo a voce alta, e con altri che ritenevano la lettura a voce alta noiosa per gli studenti, quindi preferibilmente evitabile.
Sono dubbi e preoccupazioni leciti, ma da sfatare.
Il primo movimento sta fuori e intorno l’atto di leggere.
Ho sempre associato la lettura a voce alta al fatto di poter essere visti e, nello stesso tempo, al fatto di poter scomparire.
Sul fatto di essere visti mi piace dire qualcosa su una qualità che credo sia indispensabile per l’educatore, ovvero la capacità di fregarsene del ridicolo.
Questa cosa l’ha scritta bene la Rowling in Il seggio vacante:
Tessa sapeva che gli adolescenti erano lacerati dalla paura del ridicolo. E coloro che non ne avevano – pochissimi, fra gli adulti – esercitavano un’autorità naturale sui giovani: avrebbero dovuto costringerli per legge a insegnare.
Nella scuola primaria è raro che ci si imbatta nella percezione del ridicolo (soprattutto nel primo ciclo), ma alla secondaria inferiore il ridicolo è lì, in piedi sulla porta, ogni momento, mentre i ragazzi iniziano a prendere le misure a se stessi e al mondo. E tuttavia il ridicolo è lì, sulla porta, se l’adulto lo invita ad entrare, come senso del ridicolo – perché poi, è parere mio, una tara di ridicolo l’abbiamo tutti, a meno di non voler credere di essere qualcosa di più e di diverso rispetto alla nostra umanità.
Quest’anno nelle prime e nelle terze medie leggo un piccolo pezzo del Diario d’inverno di Paul Auster, dove lui racconta di quando ha capito che la scrittura ha a che fare con le gambe, il cuore e i polmoni – che è una questione di fiato, questo:
Avevi trentun anni, il tuo primo matrimonio era appena fallito, avevi un figlio di diciotto mesi e nessun lavoro regolare, né soldi che si potessero dire tali, ti guadagnavi da vivere in modo magro e inadeguato facendo il traduttore freelance, […] il tuo lavoro era rimasto fermo, nell’incertezza, eri arenato e confuso, non scrivevi una poesia da oltre un anno e stavi lentamente giungendo alla conclusione che non saresti riuscito a scrivere più. Ti trovavi a quel punto quella sera d’inverno più di trentadue anni fa, quando entrasti nella palestra della scuola per assistere alla prova aperta della coreografia di Nina W. […] La prima cosa che ti colpì fu la mancanza di accompagnamento musicale. Non avevi mai pensato a quella possibilità – di danzare sul silenzio anziché sulla misura – perché la musica ti era sempre sembrata essenziale alla danza, inseparabile dalla danza, non solo in quanto determina il ritmo e la velocità del brano, ma in quanto stabilisce il tono emotivo per lo spettatore dando coerenza narrativa a ciò che altrimenti sarebbe del tutto astratto, ma in questo caso toccava ai corpi dei ballerini determinare il ritmo e il tono del pezzo […]. Niente suoni, perciò, a parte il tonfo dei piedi nudi sul parquet della palestra. Non ricordi i dettagli dei loro movimenti, ma nella mente li vedi saltare e roteare, cadere e scivolare, braccia agitate e braccia che ricadevano a terra, gambe che calciavano e correvano avanti, corpi che si toccavano e poi non si toccavano, e restasti ammirato per la grazia e le doti atletiche dei ballerini, ti sembrò che la semplice vista dei loro corpi in movimento ti portasse in qualche luogo inesplorato all’interno di te stesso, e a poco a poco sentisti che qualcosa in te si sollevava, sentisti una gioia fisica che era anche mentale, una gioia crescente che si espandeva in ogni parte di te.
A questo punto chiedo ai ragazzi di chiudere gli occhi, poi mi metto a “ballare” (le virgolette alte sono d’obbligo).
Essendo da sola, faccio di quelle strane cose che si fanno nella danza contemporanea, che mani e braccia toccano altre parti del corpo, e insomma faccio in modo che i miei movimenti producano un ritmo: suoni di un corpo in movimento nell’ambiente.
Chi mi vede ballare è il professore, la professoressa. Non ho idea di cosa possa pensare di me in quel momento e in quel momento, appunto, sto lavorando al senso del testo con i ragazzi (che penseranno a cosa sia un tono emotivo e scriveranno di quando sentono spirito e corpo lavorare insieme) e al senso del ridicolo con l’insegnante. Ciò che verrà dai ragazzi potrò vederlo, ciò che verrà da parte degli insegnanti mi auguro sia qualcosa come l’acquisizione implicita del valore del corpo nell’insegnamento, l’implicita consapevolezza che certe cose, ridicole o no, sono essenziali nella relazione educativa.
Il secondo movimento è concentrato sull’atto di leggere.
Ieri mattina Anna, undici anni, ha letto questo testo:
Mi sono sentita magnificamente quando è nata mia sorella, per me è stata una grande gioia perché desideravo tanto avere compagnia e non sentirmi più sola.
Nella lettura a voce alta possono agire due componenti sulla melodia e sulla velocità di esecuzione: la flessione dialettale e l’emozione.
La componente dialettale è preponderante nei bambini e nei ragazzi, pesa di meno nella performance degli insegnanti, ma si tratta comunque di un reagente cui il testo viene sottoposto e che, di città in città (e poiché non si sta parlando di lettura professionale, ovvero attoriale) non sarà ciò che rovina il testo, collocandolo anzi in una realtà geografica che per parte sua giocherà un proprio ruolo nella vitalità del testo stesso.
Poi c’è la componente emotiva che è, in sostanza, il dove siamo noi rispetto al testo che stiamo leggendo.
Riguardo a intensità, timbro, ritmo di emissione (i tre movimenti della partitura poetica di cui scrive Maurizio Della Casa in Musica, lingua e poesia), l’emozione agisce su intensità e ritmo di emissione; nei bambini, spesso, la perla vera dell’esecuzione a viva voce è il timbro, elemento unico, personale, che veste perfettamente il testo (scritto attraverso e grazie a quella voce: sulle variazioni di timbro si può e si deve lavorare, ma senza dimenticare di valorizzare il timbro ‘nudo’ che risponde all’anatomia individuale del singolo bambino).
Dunque, per tornare a intensità e ritmo di emissione, l’emozione agisce riducendo la prima e aumentando il secondo, cosa che è successa anche ad Anna leggendo il suo testo. In particolare, leggeva così velocemente non sentirmi più sola che il più e il sola costruivano a livello fonetico un unico elemento; leggeva, insomma, piùsola come avrebbe potuto leggere carriola oppure figliola o simili.
Invece qui c’è il cuore del testo: il sentirsi sola deve essere percepito nella musica del testo, e il più sola deve essere letto lentamente, con una pausa tra più e sola, una pausa che sia niente di più di uno spazio in cui la solitudine si manifesti e il testo abbia intatte le sue ragioni.
L’emozione agisce anche in un altro modo: imponendo al testo il proprio ritmo. Questo ritmo che può contaminarsi con tratti dialettali, è un andamento melodico che determina un sovratesto.
Un andamento ritmico che può essere, non so, tatatà tatatà tatatà tà (o simili) che si sovrappone al testo. Quando ciò avviene, il cosiddetto contenuto del testo va a farsi un giro largo; potremmo avere davanti il bugiardino della tachipirina, Biancaneve o Diario d’inverno e non farebbe molta differenza: chi ascolta percepirà l’andamento del fiato e il ritmo della gittata sonora della voce di chi legge come tratto dominante della lettura, come senso generale dell’esperienza dell’ascolto.
Questo avviene quando non si ha esperienza del testo e di molti testi diversi; quando si è, in un certo senso, sbilanciati su se stessi, precisamente sul me stesso che in questo momento legge, sul me stesso che in questo momento tutti stanno ascoltando – per la durata che è lo spazio occupato dalla mia voce per leggere fino in fondo quello che sto leggendo.
Si capisce bene, allora, che lavorare sulla propria voce non è solo lavorare su se stessi – all’inizio è così, certamente, ma strada facendo il leggere a voce alta deve diventare e di fatto diventa un dare voce a qualcun altro, un fare spazio a un’altra voce e alle storie che quest’altra voce ha da raccontare.
L’essere visti (per come si è) e lo scomparire (in favore dell’altro): questi due movimenti continueranno ad accompagnare attraverso e grazie la lettura a viva voce la negoziazione tra i soggetti all’interno della pratica educativa.